Economia sociale e riutilizzo, spunti di riflessione
Alessandro Giuliani
Nell’antichità era tutto unito: matrimonio, lavoro, religione, legami sociali e di solidarietà, attività produttive ed ecosistema. E’ con l’età moderna che, secondo il famoso sociologo del XX secolo Karl Polany, che tutto comincia a “disincastonarsi”. L’attività economica, lasciata a sé stessa, non incorpora più in modo strutturale gli aspetti ambientali e quelli sociali, che quindi ricadono sotto la responsabilità dello Stato e, in molti casi, rimangono abbandonati e scoordinati, fino a diventare patogeni. Non starò qui a soffermarmi sui disastri sociali ed ambientali che caratterizzano la nostra società contemporanea. Mi focalizzerò piuttosto sulle tendenze di “reincastonamento”, e su come queste riguardano il settore in cui lavoro: il riutilizzo.
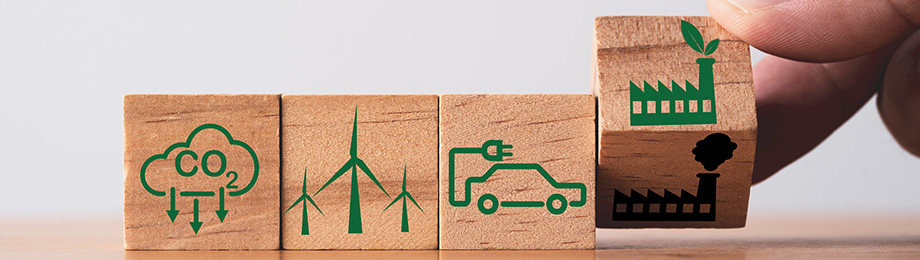
Gli Stati, con sempre meno risorse, delegano sempre di più ad enti privati la cura dell’ambiente e dell’inclusione sociale, e lo fanno in vari modi. Nel nostro settore questa impostazione è evidentissima nelle politiche di “responsabilità estesa del produttore”, che impongono ai produttori di beni nuovi di organizzare e finanziare le filiere di recupero dei beni post-consumo. Quindi privato che opera con finalità di utilità collettiva, in base a obiettivi e parametri fissati dall’istituzione pubblica. Esiste poi un evidente tendenza, più in generale, di imprenditorializzazione degli enti non profit e di incorporazione di obiettivi di utilità collettiva nelle aziende profit. I due poli del profit e non profit, fino a pochi anni fa considerati estremamente diversi e apparentemente conciliabili, sembrano convergere verso un modello unico di fare impresa e di fare economia. Non lo dico io ma lo dice Joseph Rifkin in un caposaldo della letteratura economica degli ultimi anni: “La società a costo marginale zero” (Rifkin, 20014). La tendenza convergente verso un modello “reincastonato” trova impulso sia dal mercato (le aziende del “primo mondo” applicano responsabilità sociale d’impresa e standard ambientali sempre più alti per accontentare consumatori sempre più attenti) che dalla politica pubblica (in Italia la riforma del terzo settore trasforma le cooperative sociali in imprese sociali e, parallelamente, è nata la figura della “società benefit” per le aziende che dimostrano di non agire solo a fine lucro, che poi è la strada che ho deciso di imboccare come imprenditore – vedere il Bilancio del bene comune di Leotron).
Anche in merito a queste tendenze, il settore del riutilizzo è profondamente coinvolto. Esistono infatti due anelli strategici di questo settore, dove il non profit ha una fortissima presenza: i centri di riuso e la raccolta di abiti usati. In entrambi i casi, gli enti non profit coinvolti tendono ad appellarsi alla politica perché questi spazi siano ad essi riservati, e ciò è compatibile con una diffusa linea di pensiero che riguarda anche iniziative maggiormente ludico-culturali come le feste del baratto e i repair-café. Questa linea di pensiero consiste, in sintesi, nel voler trovare nel riutilizzo e nella riparazione spazi dove il “capitalismo” entra in deroga e dove il sociale (o la socialità) hanno la possibilità di tornare al centro di un’attività produttiva, economica o di libero scambio (come accadeva nei tempi antichi e come tutt’ora accade in certi settori di economia popolare, soprattutto in Africa). Questa visione genera inevitabilmente contraddizioni quando si confronta con obiettivi ambientali o servizi pubblici, ossia con attività bisognose di produttività, vincoli di qualità e performance economiche stabili. L’esempio più lampante è quello degli abiti usati, dove a partire dal volto solidale delle cooperative sociali che svolgono il servizio di raccolta per conto dei Comuni, si snodano lunghe ed articolate filiere dove agiscono player commerciali di tutti i tipi, il cui profilo differisce significativamente dalle aspettative del cittadino che dona/conferisce il proprio abito usato nel cassonetto giallo con logo Caritas. I Centri di riuso, come abbiamo argomentato in un nostro recente articolo, si avviano verso la stessa strada delle raccolte di abiti usati e, probabilmente, verso le stesse contraddizioni (vedere l’articolo: Centri di Riuso, il punto della situazione).
Gli obiettivi ambientali hanno bisogno di volumi concreti di recupero, i volumi hanno bisogno di efficienza e imprenditorialità. Può il non profit sviluppare la capacità necessaria a raccogliere questo tipo di sfide? O è forse meglio che siano le imprese, con il loro approccio efficace ed efficiente, a incorporare gli aspetti ambientali e sociali? La risposta a questo quesito fondamentale non è semplice, e forse non esiste perché sono le basi stesse della questione a non avere un contorno definito. Quando si tratta di implementare attività economiche e produttive, in ambito ambientale così come in altri ambiti, cosa distingue realmente un ente non profit da un ente profit?
Nel 2012 la Commissione Europea ha proposto una definizione di Economia Sociale coerente con la “Carta dei Principi” prodotta dall’European Standing Conference on Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations (CEP-CMAF). Secondo la visione di UE e CEP-CMAF, le imprese dell’Economia Sociale per essere definite come tali dovrebbero:
-
Essere private, ossia non controllate dal settore pubblico;
-
Avere un’organizzazione formale e una ragione sociale legalmente definita;
-
Avere autonomia decisionale e organizzativa;
-
Distribuire profitti e surplus tra i soci non proporzionalmente alle quote di capitale immesse dagli stessi ma in base alla loro effettiva partecipazione operativa ed economica alle attività specifiche;
-
Essere organizzazioni di persone e non di capitali, che lavorano con il capitale così come con altre risorse non monetarie, ma non per il capitale;
-
Essere democraticamente organizzate in base al principio “una testa un voto”, senza concedere peso decisionale maggiore a chi ha iniettato più capitale. L’assemblea di chi lavora nell’organizzazione è sovrana e nomina la governance.
Non si tratta quindi semplicemente di essere un ente privato che persegue finalità di utilità collettiva ma occorre anche, essenzialmente, essere una cooperativa. A questa discriminante va attribuito un carattere puramente ideologico o contribuisce veramente, in sé stessa, al raggiungimento di risultati sociali e ambientali?
Il noto filosofo Toni Negri, quando parla “biopower”, si riferisce alla forza sprigionata dal basso dai cittadini per perseguire autonomamente obiettivi di miglioramento o trasformazione del mondo. Una logica volontaristica, libera ed auto-organizzata, il cui spirito appartiene a ciascuna delle persone coinvolte, in quanto ognuna di esse è in qualche modo “padrona” dell’attività che sta svolgendo. Questa sembra essere l’essenza della definizione di Economia Sociale che abbiamo appena visto. Chiarite le premesse teoriche, cosa accade poi nella realtà? Nella realtà accade di tutto: cose meravigliose e cose pessime, e non credo sia necessario riepilogare in questa sede le cronache che lo dimostrano.
Alla luce dei ragionamenti accennati, pongo quindi alcuni spunti di riflessione, che intendono essere aperti, migliorabili e ripensabili nel quadro di una dialettica onesta e costruttiva. Le mie riflessioni riprendono in parte i ragionamenti proposti dall’amico Aldo Barbini, esponente storico dell’economia sociale veronese che è stato recentemente intervistato da Leotron (vedere: Mattaranetta: il non profit innovativo).
L’aspetto “democratico” che in Europa viene proposto come requisito definitorio dell’Economia Sociale, appartiene in teoria a tutte le cooperative, ma esistono molti modi di aggirarlo internamente: le relazioni di forza non si misurano solo in base agli statuti. Ma quando l’aspetto democratico è realmente vigente, ossia si basa su un’autentica partecipazione dei lavoratori/attivisti, è possibile, se non probabile, che la finalità principale dell’ente diventi proteggere il più possibile la stabilità lavorativa della compagine. Il conflitto capitale/lavoro non esiste in queste realtà, è il lavoro a vincere e a dominare. Ciò significa che il profitto (in quanto risultante dalla differenza tra ricavi e costi, includendo il costo del lavoro) realmente non viene ricercato, coerentemente con lo status di “non profit”; ma il rischio è che la finalità sociale stessa, in alcuni casi, smetta di essere la vera priorità ma solo un modo per ricevere finanziamenti pubblici o per vincere appalti con gare riservate. Questo tipo di logiche non favoriscono l’efficienza da nessun punto di vista, e ciò rischia di inibire la possibilità di raggiungere gli importanti risultati sociali ed ambientali di cui la collettività ha bisogno. Specularmente, le imprese profit che incorporano finalità sociali ed ambientali, rischiano di non perseguirle seriamente laddove gli unici indicatori di risultato che interessano a soci ed azionisti sono quelli relativi alla distribuzione delle quote di profitto; in questi casi le finalità sociali ed ambientali, lungi dall’essere il cuore della strategia dell’impresa, sono relegate agli uffici di comunicazione e marketing e rimangono una mera questione di immagine. “Green washing” e “Social washing”, a buon diritto, sono diventati termini di vocabolario comune.
Che il dibattito inizi! Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi altri autori verranno chiamati a dire la loro su questi temi.